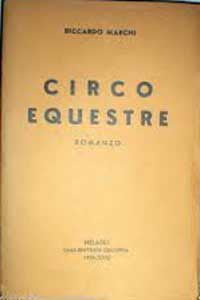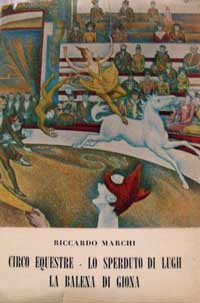|
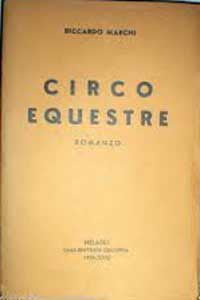
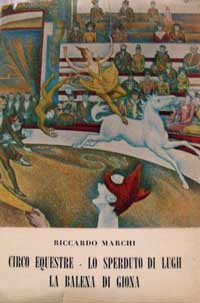
|
Riccardo
Marchi (1897 - 1992) è davvero un personaggio
dimenticato nel panorama letterario italiano,
cercando in rete si trova pochissimo su di lui,
addirittura, digitando il suo nome sui principali
motori di ricerca, ci siamo imbattuti, fra i
primi risultati, nella nostra stessa citazione
sulla pagina Facebook di Livorno Magazine. Eppure,
Riccardo Marchi è stato paragonato dalla
critica a Tozzi, a Verga e a Capuana, per il
realismo della descrizione e per il suo essere
studioso del folclore e delle tradizioni livornesi.
Telegrafista nella prima guerra mondiale, gestì
con successo la fabbrica di sapone del padre,
portando avanti, contemporaneamente, l'attività
di giornalista, di scrittore e di attivista
politico. Nel 1921 partecipò da cronista
al convegno socialista che vide la nascita del
partito comunista.
Oltre ai versi e a numerosi romanzi, molti dei
quali di stampo rievocativo e genericamente
autobiografico, ottenne anche un discreto successo
via etere come autore di radiodrammi e radio
fiabe. Divenne membro, insieme a Corrado Alvaro,
di una autorevole commissione dell'E.I.A.R.
Nel secondo dopoguerra si dedicò alla
cronaca e critica cinematografica per "IL
Telegrafo" e "Il Tirreno".
Sul finire degli anni sessanta si ritirò
a vita privata a Livorno, dedicandosi esclusivamente
alla scrittura. Morì nel 1992.
I suoi romanzi più conosciuti sono: "Circo
Equestre", "Lo sperduto di Lugh"
ma, soprattutto, "Via Eugenia, 1900",
dove rievoca la vita della sua famiglia, la
fabbrica del sapone, la figura di Zio Tide,
galantuomo d'altri tempi.
"Un
galantuomo! Vallo a cercare al giorno d'oggi.
Zio Tide lo fu? Sicuramente lo fu.
Il discorso mi riporta necessariamente alla
memoria di lui, di zio Tide, abbreviativo di
Aristide, fratello di mia madre, esempio di
galantomismo non gratuito o di poco costo, pagato
anzi a caro prezzo.
Com'era nel fisico? Aitante con un volto bruno
come scavato sulla scorza di un vecchio albero.
Di apparenza burbero; in realtà bonario,
rivelato nell'intimo da un non frequente sorriso
che, schiarendolo, gli animava assieme allo
sguardo, i cespugli arruffati degli scopettoni
e i baffi da quarantottino. " (pag.7)
Marchi
aveva "il tratto dell'incisore", come
si afferma nella prefazione a cura dell'editrice
Nuova Fortezza, e sapeva rendere le strade di
Livorno con animata vivacità:
"E
la strada della fanciullezza com'era?
Pressappoco come oggi, più decorosa,
più Eugenia, da un Eugenio magistrato
civico.
|
Allora,
nonostante la saponeria e la fonderia limitrofa al
termine di quel tratto di strada, nonostante qualche
stallatico e due o tre botteghe di artigiani ed una
modesta canova, nei sedici edifici che la compongono,
fra i quali due palazzine padronali, via Eugenia ospitava
con signorile dignità impiegati, artigiani
e Liberi Imprenditori come noi.
Ora è trasandata, decaduta, coi muri scrostati
e fioriti di erbacce, butterati dalle guerre; ma ai
tempi di zio Tide, come garriva! Di panni al sole,
di voci attestanti una vitalità calda; perfino
di ricchezza.
La ravvivava dall'alba al tramonto, il cantare degli
ambulanti: le erbaiole, l'arsellaio, il pesciaiolo,
il pollaiolo, l'ombrellaio, l'arrotino, il ramaio
di Prato, un cenciaio e così via dicendo. Polifonia
alla quale, per solleticare il buon cuore, si univano
le tiritere degli organetti. A questi Tide faceva
l'elemosina di un soldo purché se ne andassero
altrove a infastidire con "La vergine degli angeli"
o "La donna è mobile". Tornassero,
magari, col repertorio nuovo e lo strumento accordato."
(pag. 19)
"Via
Eugenia 1900" è una finestra sul nostro
passato, sulla Livorno appena uscita dal Risorgimento.
Ci viene in mente l'angolo nascosto del cimitero dei
Lupi con le tombe garibaldine crepate, inselvatichite,
ed è spontaneo associarle - e confrontarle
- con certe descrizioni del Marchi:
"Ah,
tempi gagliardi, bellissimi e feroci! Li ricordo ancora
per i cortei, riti del popolo che se ne nutriva, come
il pane. I funerali dei garibaldini cui partecipavo
tenuto per mano dallo zio. Grande sfoggio di bandiere
e camicie rosse; folla di severi uomini in nero, come
lo zio: tutti quanti con una rappa di acacia all'occhiello."
(pag 41)
|